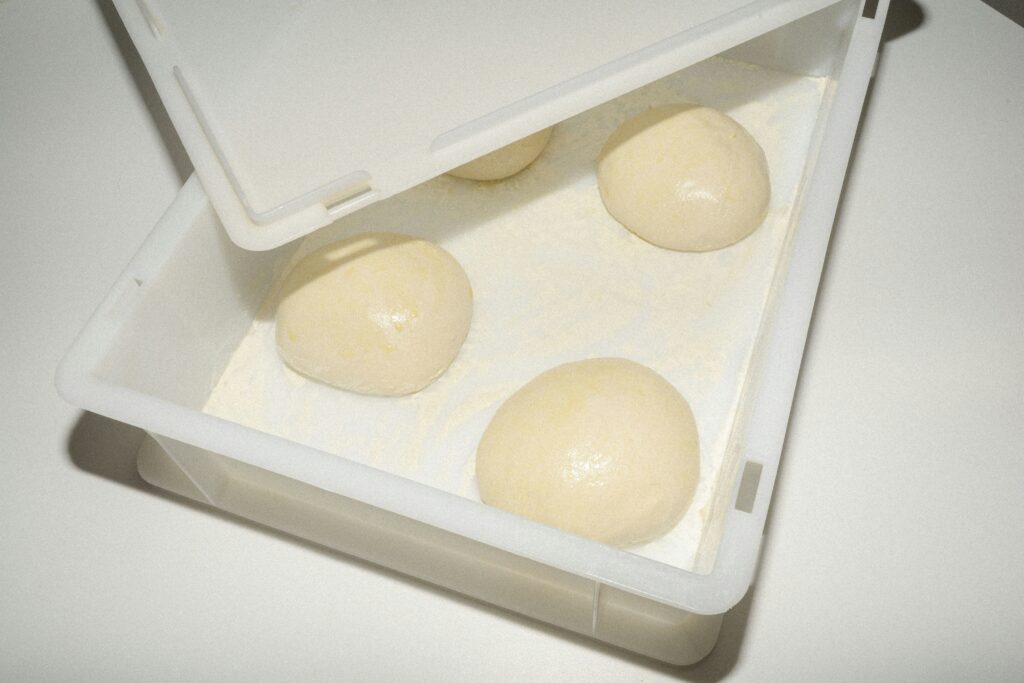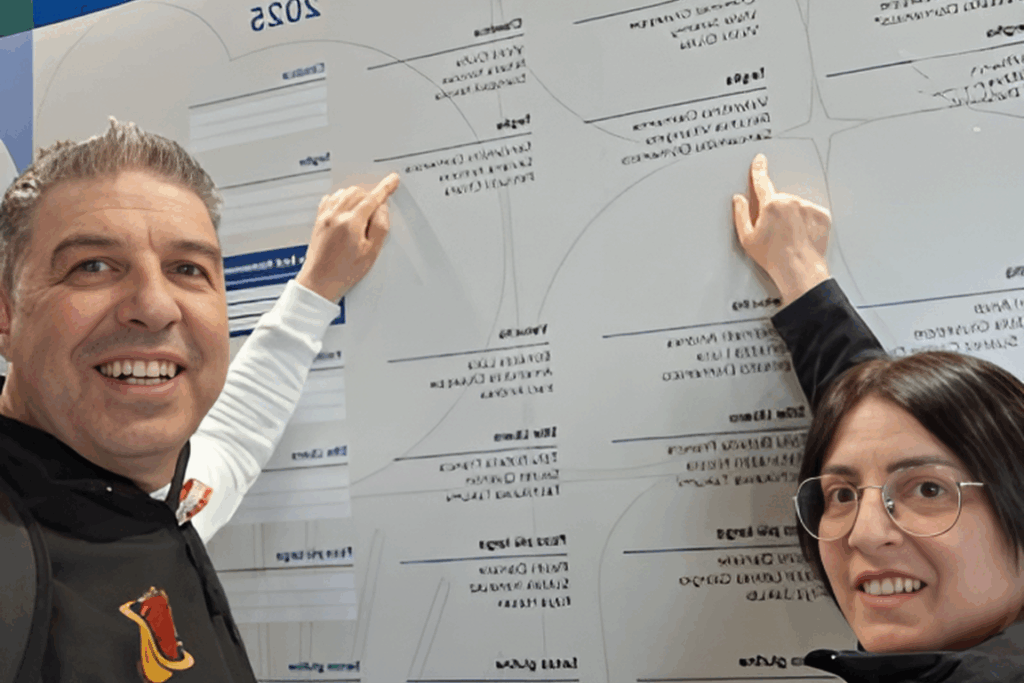Perché la dieta mediterranea viene considerata tra le migliori al mondo? Scopriamolo attraverso il viaggio e gli studi dei coniugi Keys.
Ancel e Margaret Keys, i coniugi che scoprirono i segreti della longevità delle comunità del Mare Nostrum, codificando la Dieta Mediterranea, venivano dagli States, più precisamente da Minneapolis.
Decisero però di costruire la loro dimora estiva in Cilento, a Pioppi. Da quella casa si vedeva l’antica Velia, la città dove Parmenide e Zenone avevano dato vita alla cultura eleatica. Per questa commistione di emozioni tra il nome della loro terra d’origine e quella della ragion d’essere della cultura occidentale chiamarono Minnelea la loro abitazione in Campania. Fu proprio qui, in questa casa, che scoprirono e valorizzarono i prodotti, le tecniche di preparazione, l’organizzazione dei pasti e la scansione rituale che sono alla base della Dieta Mediterranea.
Ancel Keys nel 1961 conquistò la copertina del Time come “uomo dell’anno”. Attraverso i suoi studi, aveva infatti scoperto gli effetti del colesterolo, mettendo in relazione – per la prima volta dopo secoli di scientismo – alimentazione e salute. Keys giunse a questa scoperta in maniera del tutto casuale. L’antropologa Elisabetta Moro, che dirige con Marino Niola il MedEatResearch – Centro di ricerche sociali sulla Dieta Mediterranea dell’Università “Suor Orsola Benincasa” di Napoli, spiega: «La scoperta della Dieta Mediterranea ha un inizio ed è il 1951, quando Ancel Keys arriva a Roma invitato dalla FAO. La FAO ha organizzato un grande convegno per riorganizzare la nutrizione di tutta l’Europa uscita dalla II Guerra Mondiale. Keys in quel momento è il più famoso nutrizionista e fisiologo del mondo perché ha inventato la Razione K, la razione alimentare dell’esercito americano inventata inizialmente per i paracadutisti ma poi adottata da tutti i soldati perché comodissima: la Razione K era un kit alimentare per sopravvivere un paio di giorni. Ancel Keys non era famoso solo per questo ma anche per l’importantissimo studio “The biology of human Starvation”, ancora oggi insuperato, sugli effetti della fame sul nostro corpo. Proprio per queste due ragioni Keys viene invitato a presiedere la sessione inaugurale e si ritrova con tutti colleghi che parlano di mancanze nutrizionali». Keys però ha un cruccio che lo attanaglia: Il 50% dei maschi adulti americani nel 1951 moriva di infarto. Pone dunque questa questione sul tavolo ai suoi colleghi ma nessuno si rende conto che di lì a poco il problema americano sarebbe diventato problema del mondo intero. Nessuno lo ascolta, dunque, eccetto uno: Gino Bergami. Bergami è un giovane medico napoletano che si avvicina a Keys per spiegargli il motivo di quel disinteresse da parte della comunità scientifica e rivelando così al professore che a Napoli, per esempio, non c’erano casi di infarti del miocardio, se non rarissimi. Al suo rientro a Oxford, dove stava svolgendo l’anno sabbatico, Keys decide di inviare un telegramma a Bergami chiedendogli se fosse proprio vero quanto gli avesse detto. Scrive Elisabetta Moro: «E Bergami gli risponde con un altro telegramma: “Certo professore, ma venga a verificare lei stesso”. In un ulteriore telegramma Ancel Keys dice: “Stiamo arrivando”. In quel “stiamo” c’è la chiave di questa storia». Keys arriva a Napoli con sua moglie Margaret e nel 1951 lavora con lei allo screening della popolazione maschile napoletana tra i 39 e i 59 anni, scegliendo la classe sociale meno abbiente formata dai vigili urbani e dagli operai dell’Italsider. Attraverso le analisi del sangue, i coniugi Keys scoprono che la discriminante tra gli americani e i napoletani era nel colesterolo. Dal 1957, Keys approfondirà questi temi con il Seven Countries Study (che coinvolge Italia, USA, Finlandia, Jugoslavia, Giappone, Olanda e Grecia), al fine di comparare gli stili di vita di queste nazioni. Da quel momento la sua passione per l’Italia aumenterà sempre più.

I risultati degli studi dei coniugi Keys iniziano a fare la propria apparizione nelle librerie americane nel 1959 quando viene edito “Eat Well and Stay Well”. Qualche anno dopo, nel 1967, Keys darà alle stampe una monografia dedicata alla “alternativa proteica” della carne, ossia i legumi, in particolare il fagiolo: “The benevolent bean” è ritenuto a giusta ragione uno dei tre pilastri della ricerca sulla “mediterraneità”. A chiudere la trilogia, una riedizione del primo libro ampliata, riveduta e aggiornata con tantissime ricette: nel 1975 esce “How to eat well and stay well. The Mediterranean Way”. In questo volume, non solo fa la sua comparsa nel titolo la voce “Dieta Mediterranea” ma da ogni pagina emerge la “Mediterranean way of life” che seduce Keys. Dieta è un termine troppo spesso usato con significato privativo ma è assolutamente improbabile che fosse questo il senso attribuitogli da Keys. Basti pensare che la narrazione scientifica cede il passo alla divulgazione ma soprattutto alle storie delle comunità cilentane, comunità che sono “slow food” ante-litteram. Dieta è dunque un sostantivo che Keys utilizza con l’antichissimo senso greco di “casa” ma anche di “stile di vita”. Ed è per questo che per noi continuerà a essere una “bella parola”. La cucina protagonista dei libri di Keys è priva di dolci fatti con zuccheri raffinati ma non priva di dolcezza: compaiono infatti i cibi delle feste e sappiamo che “il professore” non disdegnasse la dolcezza del fico dottato del Cilento (oggi il fico “monnato” è Presidio Slow Food) che mangiava ogni sera prima di dormire. A rivelarcelo è Delia Morinelli, cuoca di casa Keys, a cui si devono tanti aneddoti sulla coppia più amata del Mediterraneo e anche molte delle ricette che si trovano nel libro.

Molto spesso ho pensato che mi sarebbe piaciuto vivere accanto ai Keys e scoprirne le passioni. Sarà che, ascoltando Delia Morinelli nell’intervista raccolta da Elisabetta Moro per il Museo virtuale della Dieta Mediterranea o incontrando i centenari, oggi molto numerosi in Cilento, mi sono reso conto delle straordinarie qualità umane del “professore americano” (come lo chiamano ancora oggi in Campania), qualità che gli hanno consentito di approfondire le basi della “mediterraneità” ben oltre gli alimenti e soprattutto di imprimere una traccia indelebile nel cuore delle genti del luogo. La Dieta Mediterranea però non è qualcosa di intoccabile. E forse la sua forza è proprio quella. Keys ci ha fatto comprendere che non è necessario alimentarsi tutti per sempre allo stesso modo bensì è fondamentale riuscire a innovare, azione per la cui riuscita è più importante avere una mente attiva che un portafogli bello pieno (parafrasando la giornalista Simran Sethi, autrice di “Bread Wine Chocolate”). Per questo motivo, di recente, Marino Niola ed Elisabetta Moro hanno scritto insieme ad Andrea Segrè e Pierluigi Petrillo un libro dedicato a chi vuole scoprire “i segreti della Dieta Mediterranea”. Oltre a ripercorrere la storia sociale della scoperta dei Keys, il libro ha una sezione di ricette molto ampia dove compaiono le ricette contemporanee della Dieta Mediterranea secondo le voci dei cuochi delle Osterie d’Italia di Slow Food e gli chef stellati della guida Michelin. Così, accanto al baccalà vesuviano di Angelina Ceriello de ‘E curti di Sant’Anastasia, si trova quella della triglia con fave e cicoria di Alessandra Civilla di Lecce. Parimenti, la Dieta Mediterranea non è neppure questione meridionale, come pure si è tentato di dire nel tempo perché è tutelata e valorizzata tanto dallo stellato ischitano Nino Di Costanzo quanto dal cuoco pensatore fiorentino Fabio Picchi. Insomma, la Dieta Mediterranea è Patrimonio Mondiale dell’Umanità (riconosciuto dall’Unesco il 10 novembre 2010) proprio perché con le nostre abitudini quotidiane possiamo difenderla e promuoverla, divenendone ambasciatori.
Siamo giunti alla fine e non abbiamo parlato di alimenti, di cibo, di consigli nutrizionali. Perdonate la franchezza ma quello lo trovate scritto ovunque. Il mio consiglio è di partire da qui.